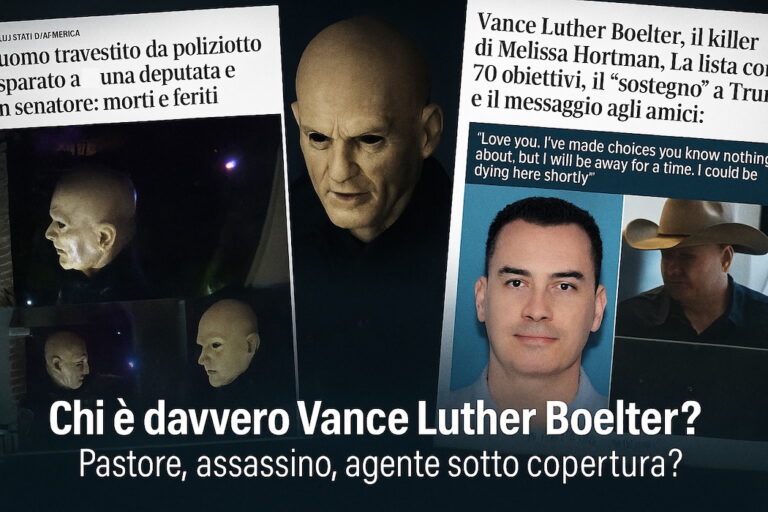(AP Photo/Alessandra Tarantino)
© Filippo Chinnici
Dal Medioevo all’era digitale, l’elezione del papa si svolge formalmente in clausura assoluta. Ma è davvero possibile isolare la Chiesa dal mondo? Un viaggio tra storia, liturgia e strategia ecclesiale.
Contenuti
- 1. Origini storiche: Viterbo, 1268–1271
- 2. Rito, regole e dinamiche contemporanee
- 3. Dal conclave italiano a quello universale
- 4. Clausura assoluta nell’epoca digitale: realtà o finzione?
- 5. Il conclave e le influenze invisibili
- 6. Ombre e silenzi: il vero volto del conclave?
- Appendice – Il papato: costruzione storico-ecclesiastica e non istituzione neotestamentaria
1. Origini storiche: Viterbo, 1268–1271
Il termine «conclave» — cum clave, «chiusi a chiave» — non nasce da una liturgia, ma da un’urgenza storica: la paralisi dell’elezione papale successiva alla morte di Clemente IV, durata quasi tre anni. L’impasse tra le fazioni dei cardinali italiani e francesi rifletteva una frattura non solo geografica, ma anche ecclesiologica e politica, in un’epoca in cui il papato oscillava tra indipendenza e controllo imperiale.
Il popolo di Viterbo, esasperato, murò letteralmente i cardinali all’interno del Palazzo Papale. Il gesto non fu solo simbolico: fu un atto di teologia politica dal basso, che costrinse la Curia a superare lo stallo con l’elezione di Teobaldo Visconti (Gregorio X), figura esterna al Sacro Collegio.
La svolta istituzionale giunse con la Ubi Periculum (1274), che trasformò una reclusione forzata in norma canonica:
- Clausura obbligatoria,
- Riduzione progressiva del vitto in caso di stallo (poi abolita nel XX secolo),
- Votazione quotidiana con maggioranza qualificata (2/3).
Dal 1878, i conclavi si tengono stabilmente nella Cappella Sistina, cuore spirituale e iconografico del potere papale.
Storici come Joseph Lynch e Walter Ullmann sottolineano come la formalizzazione del conclave rappresenti un raro caso di riforma ecclesiastica imposta dalla necessità storica, più che dall’autorità dottrinale.
2. Rito, regole e dinamiche contemporanee
Il conclave si apre con l’invocazione solenne Extra omnes: è l’evocazione di uno spazio teologicamente separato dal mondo, uno «spazio sacro» nel senso foucaultiano. Tuttavia, le regole canoniche codificate nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis (Giovanni Paolo II, 1996) descrivono un processo di raffinata ingegneria del silenzio:
- Alloggio riservato nella Domus Sanctae Marthae,
- Spostamenti controllati verso la Cappella Sistina,
- Quattro scrutini giornalieri (due al mattino, due al pomeriggio),
- Sospensione totale di ogni contatto con l’esterno.
Ogni giornata è scandita da un ritmo solenne e reiterato: preghiera, colloqui riservati, pasti comuni, celebrazione eucaristica. Il conclave non è dunque un semplice ritiro spirituale, ma un evento teologico-politico in cui si fonde la funzione sacramentale della successione apostolica con una sofisticata gestione del consenso e dell’autorità.
La ritualità liturgica del conclave serve anche a ricostruire visibilmente un’unità ecclesiale che, in realtà, è attraversata da tensioni profonde e non sempre componibili. Essa svolge una funzione simbolica: restituisce al mondo l’immagine di una Chiesa che, pur ferita da divisioni, si mostra in atto di discernimento corale sotto la guida dello Spirito. Ma anche l’armonia esibita può essere, talvolta, frutto di un equilibrio fragile e strategicamente costruito.
3. Dal conclave italiano a quello universale
Per oltre cinque secoli, il conclave fu una prerogativa europea, in particolare italiana, rispecchiando l’equilibrio geopolitico, culturale ed ecclesiale dell’epoca. In quel contesto, la geografia del potere spirituale era strettamente intrecciata con le dinamiche delle grandi famiglie cardinalizie, delle monarchie cattoliche e delle cancellerie europee.
Solo nel Novecento, con Paolo VI e ancor più con Giovanni Paolo II, si è avviata una reale internazionalizzazione del Sacro Collegio, culminata simbolicamente con l’elezione di papa Francesco, primo vescovo di Roma proveniente dall’America Latina. L’apertura a nuovi continenti non ha solo modificato la geografia del conclave, ma ha introdotto nella Chiesa universale un pluralismo teologico, pastorale e antropologico mai sperimentato prima su scala globale.
Oggi i cardinali provengono da oltre 60 Paesi. Questa diversità etnico-pastorale ha implicazioni concrete nel discernimento: si confrontano visioni ecclesiali che spaziano dalla teologia della liberazione alla pastorale delle minoranze, dalla dottrina ortodossa africana alla secolarizzazione europea.
Il conclave moderno è meno un’arena dove si scontrano ideologie teologiche, e più un nodo in cui si riflettono i climi pastorali delle Chiese locali. Le scelte non emergono più da mere contrapposizioni dottrinali, ma da una complessa interazione di sensibilità pastorali, urgenze geopolitiche e percezioni della missione ecclesiale nel mondo contemporaneo.
4. Clausura assoluta nell’epoca digitale: realtà o finzione?
È davvero plausibile che, nell’epoca dell’interconnessione globale e della comunicazione istantanea, i cardinali riuniti in conclave siano completamente ignari di ciò che accade all’esterno? È ancora possibile isolare uomini di governo, profondi conoscitori della realtà ecclesiale e geopolitica, dalle dinamiche del mondo?
La normativa vigente, codificata nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis (1996), vieta espressamente l’uso di qualsiasi dispositivo elettronico, telefono, computer o accesso a reti digitali. Le misure adottate dal Vaticano per garantire la clausura includono:
- Schermature elettroniche di frequenza per bloccare ogni segnale in entrata o in uscita,
- Bonifiche ambientali con rilevamento di dispositivi nascosti,
- Sorveglianza continua da parte della Gendarmeria vaticana, con controllo degli accessi alla Domus Sanctae Marthae.
Sul piano formale e canonico, la clausura è totale. Ma sul piano operativo e comunicativo, essa appare sempre più come un gesto simbolico, un rituale che suggella una decisione in buona parte già maturata.
In un’epoca dominata dalla trasparenza forzata, ogni spazio di silenzio rischia di apparire non tanto impenetrabile quanto ambiguo: un’illusione necessaria, utile a legittimare l’esito di una scelta già orientata. L’isolamento fisico non garantisce l’isolamento strategico. Come nel passato, anche oggi esistono cordate, influenze preordinate, messaggi criptici, e talvolta – secondo voci mai del tutto smentite – perfino tentativi di captazione tecnologica.
Il conclave, dunque, non sfugge alla tensione moderna tra sacralità e controllo, tra clausura e trasparenza, tra volontà divina e pianificazione umana.
5. Il conclave e le influenze invisibili
La storia dei conclavi è intessuta di interferenze, sottili o esplicite. Dal conclave del 1534, in cui Carlo V intervenne militarmente per orientare l’elezione, fino alle pressioni delle diplomazie ottocentesche e alle strategie mediatiche del mondo contemporaneo, la scelta del papa è sempre stata oggetto di attenzioni non spirituali.
Oggi tali influenze non si manifestano più con eserciti o lettere sigillate, ma attraverso dinamiche molto più sofisticate e pervasive:
- Cordate di lungo corso costruite su affinità teologiche, geopolitiche o culturali,
- Consultazioni riservate nei mesi precedenti alla clausura,
- Codici comportamentali taciti che regolano endorsement e silenzi,
- Narrative costruite ad arte attraverso i media per orientare l’immaginario ecclesiale globale.
Il conclave non è un vuoto pneumatico spirituale: è un crocevia di proiezioni, memorie e interessi. I cardinali entrano nella Sistina con una storia alle spalle, con relazioni consolidate, con promesse forse solo sussurrate. Alcuni nomi emergono prima ancora che le votazioni inizino, e alcune immagini ecclesiali sono già state proiettate nel cuore dell’opinione pubblica globale.
Il teologo francese René Laurentin osservava con lucidità: “Più che scegliere un papa, i cardinali ratificano un’immagine ecclesiale che ha già iniziato a imporsi.” In tale prospettiva, il conclave non è solo il luogo di un’elezione, ma lo specchio sacralizzato di un lungo processo di prefigurazione culturale e strategica.
6. Ombre e silenzi: il vero volto del conclave?
Alla fine, la domanda resta: è mai esistito un conclave completamente chiuso al mondo?
Probabilmente no. Il conclave è piuttosto un velario, una tenda sacra — come quella dell’Arca nel deserto — dove si attua un’azione che pretende di appartenere esclusivamente a Dio, ma che non può evitare di essere influenzata dalle debolezze e dalle strutture del mondo.
La dimensione ieratica della Cappella Sistina, con gli affreschi michelangioleschi che narrano il dramma della creazione e del giudizio, è il teatro perfetto per questo doppio movimento: tra la preghiera e la strategia, tra la grazia e l’equilibrio politico.
E così, anche oggi, mentre le porte si chiudono con il comando Extra omnes e le guardie svizzere sigillano gli accessi, qualcosa continua a filtrare: non attraverso i muri, ma attraverso le memorie, i legami, le promesse, gli intrighi, le minacce e i silenzi.
Come ricordava il cardinale Martini:
Nel conclave si prega molto. Ma si decide anche, e le due cose non sono mai isolate.
Appendice – Il papato: costruzione storico-ecclesiastica e non istituzione neotestamentaria
Sebbene il conclave sia oggi percepito come uno dei momenti più solenni e ritualizzati dell’ordinamento cattolico, esso non affonda le proprie radici nella struttura ecclesiologica neotestamentaria, bensì in un’elaborazione storico-dogmatica post-apostolica, frutto di progressive stratificazioni canoniche, politiche e simboliche.
Le chiese apostoliche: una guida collegiale, non un’episcopato monarchico
L’ecclesiologia delle prime comunità cristiane, come attestano gli scritti del Nuovo Testamento, si fondava su una conduzione collegiale. I termini presbýteroi (πρεσβύτεροι, anziani) ed epískopoi (ἐπίσκοποι, sorveglianti) appaiono spesso come intercambiabili (cfr. Atti 20:17,28; Tito 1:5–7), e designano un governo plurale, diffuso, comunitario. Non si rileva alcuna figura dotata di primato universale o di autorità assoluta sulle altre chiese.
L’assemblea di Gerusalemme, narrata in Atti 15, offre un esempio eloquente della prassi decisionale dell’epoca apostolica:
«Paolo e Barnaba, designati con altri alcuni della Chiesa, salirono a Gerusalemme… e furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani» (Atti 15:2–4).
In tale quadro, non si configura né un “vicario di Cristo” né un episcopato gerarchicamente sovraordinato. La distinzione tra vescovi, presbiteri e diaconi emerse progressivamente nel II–III secolo, per esigenze organizzative e pastorali, più che per fondamento teologico o mandato apostolico.
Il primato romano: sviluppo storico, non fondazione divina
L’identificazione dell’apostolo Pietro quale “primo papa” si basa su una lettura teologicamente contestata e contestabile di Matteo 16:18. La Scrittura non fornisce alcuna prova dell’istituzione di una successione petrina universale, né di un primato giuridico trasferibile. I Padri dei primi secoli riconoscevano a Roma un primato d’onore o di ortodossia dottrinale, non un’autorità giurisdizionale assoluta.
Le principali tappe del consolidamento papale, frutto di dinamiche storiche più che di rivelazione divina, possono essere così delineate:
- IV–V secolo: Accrescimento del prestigio del vescovo di Roma, sostenuto dal ruolo politico dell’Urbe imperiale;
- VIII secolo: Composizione della “Donazione di Costantino”, documento apocrifo volto a legittimare prerogative temporali del papa;
- XI secolo: Dictatus Papae di Gregorio VII, il primo vero Papa, in cui si afferma la superiorità del Papa su tutti i vescovi e i sovrani;
- XIX secolo: Il Concilio Vaticano I (1870) definisce il dogma dell’infallibilità papale, dottrina ignota ai primi diciotto secoli della cristianità.
Considerazioni teologiche finali
Alla luce dell’analisi storica e dell’esegesi neotestamentaria, il papato appare, da una prospettiva biblico-storica, come una costruzione ecclesiastico-istituzionale frutto dell’evoluzione del potere nella chiesa romana, più che come un prolungamento della struttura apostolica. A misura che l’Impero romano andava disfacendosi, la Chiesa di Roma andava accrescendosi in autorità, raccogliendo progressivamente l’eredità politica e simbolica dell’Urbe decadente.
Il conclave, in tal senso, costituisce l’emanazione più emblematica di una visione piramidale dell’ecclesia, fondata non sulla collegialità delle origini, ma su una verticalità autoritativa sviluppatasi nei secoli. La Chiesa del Nuovo Testamento era sinodale, non monarchica; guidata dallo Spirito Santo e dalla comunione dei santi, non da un singolo reggitore terreno. Non esiste nella Scrittura alcun successore universale di Pietro, né un solo capo visibile della Chiesa: Cristo solo è Capo, e il suo Corpo è la Chiesa intera.